Città Autistica: Ripensare lo spazio urbano attraverso la neurodivergenza
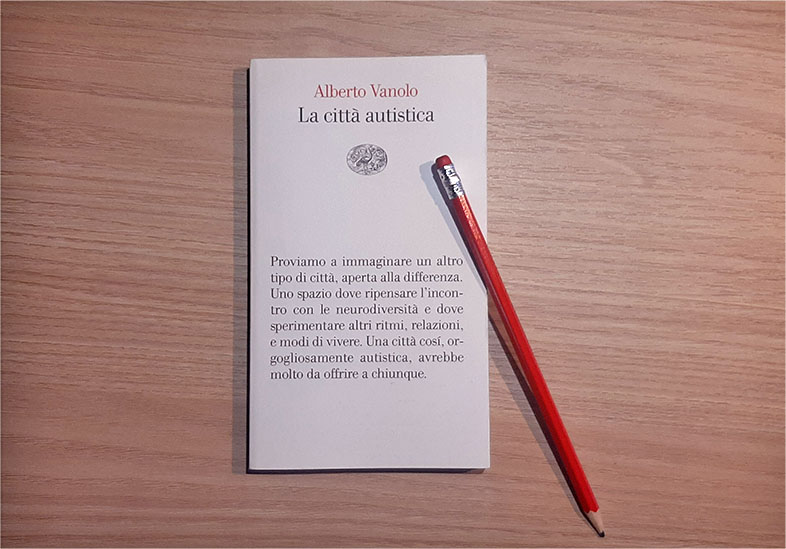
Dottoranda, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre
Alberto Vanolo, professore di geografia politica ed economica, offre un contributo innovativo al dibattito sulla giustizia socio-spaziale attraverso un’analisi dello spazio urbano osservato dal prisma della neurodivergenza. Il libro, ambientato nel contesto urbano torinese, rappresenta un tentativo sfidante di coniugare rigore accademico e narrazione personale, proponendo una prospettiva critica sulla standardizzazione degli spazi cittadini e sulle loro implicazioni con la giustizia socio-spaziale.
Fin dalle premesse (p. xv), l’autore chiarisce il suo approccio all’urbanità, intesa in senso ampio come spazio quotidiano caratterizzato da molteplici dimensioni: materiali (edifici, infrastrutture, paesaggi diversi) e immateriali (aspetti socio-culturali e simbolici). La sua critica si sviluppa contro le logiche deterministiche che tendono a normalizzare e standardizzare sia gli spazi urbani sia i comportamenti di chi li abita, sottolineando l’importanza di abilitare tutti gli abitanti senza costringerli a ridurre le loro diversità dentro norme sociali predefinite.
Il libro si struttura in una progressione che parte dalla decostruzione critica delle categorie standardizzate di “normalità” (pp. 14-17) per arrivare a proporre una visione alternativa della città. L’autore dedica particolare attenzione alla critica della misurazione dell’autismo (p. 12), evidenziando come queste pratiche di categorizzazione contribuiscano alla stigmatizzazione. Particolarmente significativa è l’analisi della “fenomenologia dell’assenza” (p. 18) e la critica al riduzionismo nelle categorizzazioni di “sano” e “malato” (p. 24).
Il secondo e terzo capitolo si concentrano sull’esperienza urbana, esplorando concetti come le passeggiate situazioniste e le esplorazioni psicogeografiche. Un contributo importante emerge nella discussione sulla progettazione degli spazi urbani (pp. 44-45), ambito nel quale Vanolo critica la tendenza a ridurre l’intensità e la varietà degli stimoli sensoriali in nome della prevedibilità e leggibilità. Come esempio pratico, cita il progetto “Vicina” a Torino (p. 48), che mappa spazi e locali attenti alle esigenze delle persone neurodivergenti, sottolineando l’importanza di una “cittadinanza tollerante, inclusiva e informata” (p. 49).
L’autore adotta una prospettiva intersezionale, evitando accuratamente di trasformare la neurodivergenza in un’identità stigmatizzante. Il suo approccio richiama la nozione di urban ambiances di Debord (1956), evidenziando come lo spazio urbano possa fungere da interlocutore attivo o da sfondo significativo nell’esperienza quotidiana, influenzando l’emotività e creando atmosfere specifiche avvolgenti.
Il capitolo quattro introduce una prospettiva particolarmente interessante, analizzando le tattiche queer e il comportamento punk come strategie radicali per affrontare il mondo urbano. Qui Vanolo si allinea con la politica queer per denunciare la stigmatizzazione dei “corpi che non producono” (pp. 77-78) e la penalizzazione di chi non si conforma agli stili di vita standardizzati del sistema capitalista. È particolarmente critico verso il prototipo della “persona autistica” come genio efficiente (pp. 76-77), apprezzato solo quando risulta utile al progresso del sistema neoliberalista delle “massime prestazioni”.
Infine, nell’ultimo capitolo, l’autore delinea la sua visione di “città autistica”, attraverso l’introduzione di quattro principi generali, proponendo idee di spazi urbani accoglienti nei confronti della (neuro)diversità, piuttosto che linee guida formali e progettuali. Smontando le soluzioni che generalizzano (p. 85), ripensa gli spazi urbani, sottolineando l’importanza della cura come “forma di solidarietà collettiva” (p. 91) e principio socio-spaziale di azione politica. Vanolo evidenzia l’interdipendenza “inevitabile, contingente e sempre reciproca” tra tutti i corpi (p. 90), proponendo una visione della città come assemblaggio di spazi di azione e collaborazione. La sua analisi, che deriva dalle teorie femministe, radicalizza le nozioni di “cura” e “inclusività” che, nonostante le varie dichiarazioni istituzionali, rimangono concetti contestati rispetto alle loro interpretazioni progettuali e applicative. La coscienza circa l’invivibilità delle nostre città (p. 83), è un altro tema che il libro affronta, proponendo un contro-paradigma basato sulla lentezza (p. 87) e sulla vita urbana comunitaria (p. 89). L’idea dello spazio urbano come spazio terapeutico di possibilità e incontri (p. 94), sebbene possa apparire generica, apre interessanti prospettive di ricerca e progettazione.
La forza del lavoro di Vanolo risiede nella sua capacità di intrecciare teoria critica, esperienza personale e proposte che compromettono un cambio socio-culturale e politico del pensiero, mirando a una città essenzialmente inclusiva. Il testo, pur mantenendo il rigore accademico, risulta accessibile e stimolante, offrendo una prospettiva originale sul rapporto tra spazio urbano e neurodivergenza. Come sottolinea l’autore stesso, la sfida principale rimane quella della comunicazione e dello sviluppo di metodi interdisciplinari e relazionali per comprendere e rispondere ai bisogni di tutti gli abitanti urbani.
La frase di conclusione “Come per ogni altra forma di marginalizzazione, devono essere i corpi delle persone oppresse a costruire le forme e i linguaggi della propria resistenza” (p.99) sottolinea la dimensione socio-politica dello spazio urbano, evidenziando come il diritto alla città si manifesti attraverso spazi (pubblici, privati, collettivi, all’aperto o al chiuso) e attraverso i corpi – mediatori dell’esperienza urbana – e trascende tutti i livelli della vita urbana. In particolare, la sua analisi illumina il duplice ruolo dello spazio urbano: da un lato come potenziale abilitatore di corpi e relazioni, dall’altro come strumento di disciplinarizzazione e normalizzazione di comportamenti considerati devianti dalla cultura neoliberale, elitista e individualista. Questo approccio critico arricchisce il dibattito sulla giustizia spaziale, collegando la neurodivergenza alle più ampie questioni di diritto all’uso e all’appropriazione dello spazio urbano.
Titolo: La città autistica
Autore: Alberto Vanolo
Editore: Einaudi
Pagine: 114
Anno di pubblicazione: 2024
Bibliografia
Bruschi, A. and Dell’Aira, P.V. (2023) Diritti e spazio pubblico nella città metropolitana. Roma e altri paesaggi. Roma: Quodlibet
Knabb K. (2006) Situationist International Anthology Revised and Expanded Edition. Canada: Bureau of Public Secrets
Massey, D. (1994) Space, Place, and Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press







