Civita
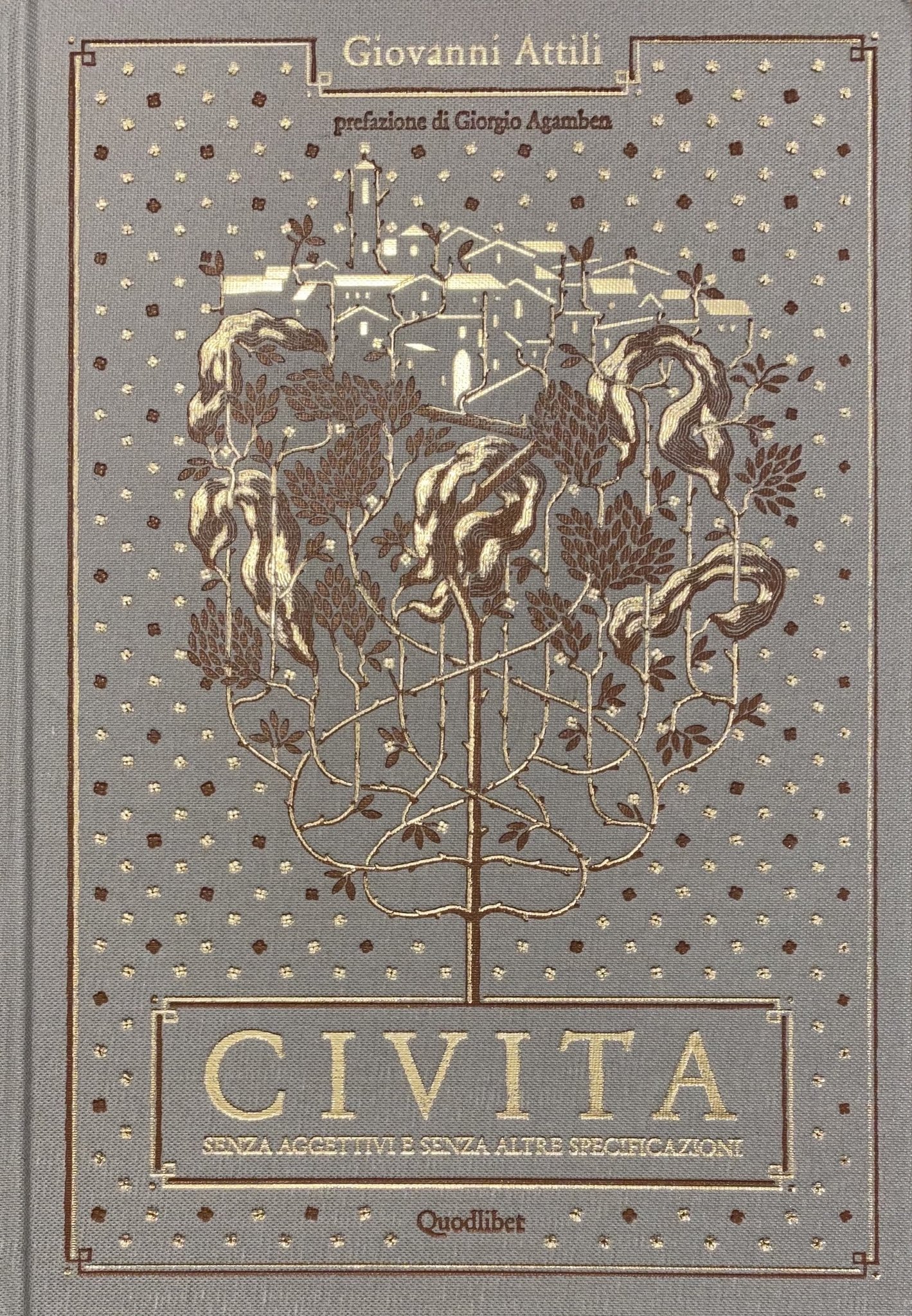
Civita, la città che resiste
Post-doc, DICEA-Sapienza Università di Roma
Già l’aspetto del volume, edito per Quodlibet nel 2020, dà l’impressione di starsi accostando a una saga, un’epopea, un poema cavalleresco il cui soggetto principale non è un umano, ma un piccolo borgo del viterbese. E in effetti quella di Civita di Bagnoregio è una storia eccezionale, raccontata in tre atti, potenzialmente autonomi ma inestricabilmente legati tra loro, che da altrettante prospettive diverse guardano alla sua fragilità e a come essa vi sopravvive.
La prima si concentra sulla fragilità geomorfologica, a cui Civita viene condannata da una terra “madre e matrigna”, fatta di argilla e tufo, erosa costantemente dall’azione di acque pluviali e torrentizie. Un’erosione che plasma il suolo, il paesaggio e la vita stessa degli abitanti del borgo, che si ostinano ad abitare una terra ostile, franosa e infeconda: “è l’urgenza di abitare che si traduce in lotta per la vita” (p.35). Il primo atto recupera il passato civitonico, ricostruendo
l’entropia quotidiana dell’affannarsi a sopravvivere, scandita dal suono delle campane, dai riti, dalle abitudini quotidiane in cui ognuno, uomo, donna, bambino ha un preciso ruolo per portare avanti il complesso meccanismo di cura del territorio che permette alla comunità tutta di abitarlo. L’abitare, in questo atto, è l’attività principale che impegna la vita: coincide con il vivere, lo riempie di senso, un senso che rivissuto attraverso lo sguardo dei civitonici può sembrare romantico, ma che in fondo è anche profondamente politico: si sopravvive in virtù della collettività, perché “semplicemente, la costruzione di una comunità solidale era l’unica possibile forma di sopravvivenza” (p.55). L’atto si conclude all’inizio degli anni ‘60, quando il processo di industrializzazione che investe tutto il Paese inscrive Civita nella “geografia dei vinti” che ancora, da allora, caratterizza migliaia di altri luoghi della penisola.
Il secondo atto guarda a una particolare tensione alla cura del borgo, inaugurato dall’architetta lettone Astra Zarina, che dal suo arrivo a Civita dagli Stati Uniti decide di adottare (e farsi adottare da) il borgo. Quella di Astra è un’adozione che comporta il mantenimento di uno sguardo al passato, attraverso un attento studio dei caratteri architettonici e le tecniche di costruzione locali, e uno al futuro, assumendo una prospettiva progettuale per consentire un rifiorire del borgo, ricollegandolo alle valli circostanti. Un’adozione che necessita di un enorme lavoro di mediazione per superare la diffidenza dei civitonici nei confronti suoi e degli studenti statunitensi della scuola residenziale che organizza ogni anno riuscendo a costruire, nei mesi estivi, “una comunità porosa, allargata, innestata da presenze transitorie” (p.140). E con il passare del tempo la temporaneità della collettività studentesca si fonde con quella di una nuova popolazione di “figure eccentriche, fuori misura” (p.149) che vedendo in Civita un possibile luogo per l’esercizio di una libertà altrove compromessa, innesca una dinamica di acquisto e ristrutturazione di molti degli immobili fatiscenti del borgo. Gli esiti dell’innesto di questa comunità intellettuale e internazionale sono indagati da Attili nelle ambiguità che generano, dalle pratiche di vita inedite ma dal rischio di un sapore colonialista fino allo schieramento nella lotta contro l’improbabile macro-progetto che minaccia il territorio.
Conflitti e nuove forma di residenzialità contribuiscono a riaccendere i riflettori sul borgo, introducendo il distopico atto finale, in cui Civita si scopre “Terra di spettacolo”. Un emblematico fenomeno di eterogenesi dei fini vede l’impeccabile ristrutturazione del patrimonio immobiliare, portata avanti sotto la guida di Astra, proporre Civita come “oggetto estetico”, una “figurazione iconica di un’identità memoriale coerente e comunicabile” (p. 264) che incontra perfettamente i gusti e i desideri dell’industria turistica. Il mito dell’autenticità cristallizza il borgo nella forma museale che ben conosciamo, arrivando alla sconcertante stima di un milione di turisti per il 2018 (a fronte di 10 residenti stabili e 40 proprietari di seconde case).
Come in una tragedia greca, Attili dialoga con un coro mutevole, che si arricchisce in ogni atto delle voci necessarie a raccontarlo. Sono le voci degli autori che hanno studiato e narrato Civita, le voci di chi vi è nato e ha dovuto lasciarla e di chi invece continua ad abitarla, cercando una surreale parvenza di vita quotidiana nel bel mezzo di un parco a tema per visitatori da tutto il mondo. Giovani, anziani, turisti, proprietari di seconde case, il coro è composto da personaggi profondamente lontani per età, cultura e soprattutto classe, che interrogano con l’autore passato, presente e futuro del borgo. Le storie personali si fanno spazio grazie a un lavoro di interlocuzione non scontato, che rispecchia la dedizione con cui Attili ha costruito la sua ricerca, di cui si può rintracciare qualche indizio importante anche nella cura dell’opulento apparato iconografico che costella il libro.
Dicevamo all’inizio che l’impressione, quando si legge di Civita, è di avere a che fare con una saga, e quindi una storia eccezionale, la vicenda di un luogo che esaspera alcuni dei meccanismi della contemporaneità a tal punto da non poter essere davvero considerato come esempio di dinamiche diffuse nell’ordinarietà dell’oggi.
Nonostante ciò, il racconto di Civita imbocca spunti per chiunque si interessi dei territori attuali: l’abbandono del borgo negli anni ‘60 aggrava la sua vulnerabilità geomorfologica, interrompendo tutte quelle pratiche di manutenzione messe in atto da secoli grazie alle antiche forme di autoregolamentazione della comunità insediata, come gli statuti medioevali. Vere e proprie pratiche di cura territoriale, spesso legate alle diverse forme di proprietà collettive presenti su gran parte del territorio italiano, fondamentali per la capillare gestione delle risorse naturali che consentono (penso alla rinnovata attenzione sulle comunanze agrarie, le vicinie, le partecipanze).
Ma il tema della cura di un territorio emerge anche dalle esperienze di Astra Zarina, della scuola residenziale e dei nuovi abitanti, pioniere di alcune delle pratiche che vediamo prosperare nelle cosiddette “aree interne” italiane e che sperimentano, intenzionalmente o meno, forme modalità abitare temporaneo, con tutte le loro ambiguità: basti pensare alla recente ondata di riscoperta di tali aree, connessa alla fuga dalle città riproposta nel discorso pubblico dall’attuale periodo pandemico. Borghi, dunque, percepiti come spazi di libertà per comunità nomadi, che possono costruire quel ponte per riabitare “altrimenti” luoghi in spopolamento ma che continuano a correre il rischio di innescare fenomeni di eterogenesi dei fini, soprattutto in assenza di politiche pubbliche di sostegno alle nuove residenzialità e all’accesso ai servizi di base.
E proprio tali politiche vedono, ancora troppo spesso, l’atterraggio sui territori di progetti eteroconcepiti, grandi opere per improbabili operazioni di rilancio territoriale (nel caso di Civita, un macro-Centro Convegni e Formazione), o l’insistenza sulla proposta di una monocoltura turistica come unico possibile volano per lo sviluppo locale, la questione centrale emblematicamente problematizzata dal volume.
Ma guardando al conflitto scatenato dalle proposte per il governo di Civita, nel libro sono rintracciabili questioni più ampie, che investono pianificazione e governance territoriale: come definire la popolazione “locale”? Con quali criteri riconoscere la legittimità di una comunità ad esprimersi su un territorio? E quali soggettività restano escluse o silenziate da tale processo? In estrema sintesi, di chi è il territorio?
Ancora, il senso stesso dell’architettura e dell’urbanistica, che aldilà della produzione di progetti e piani sono chiamate ad attivare processi che liberino visioni di futuri possibili, assunto particolarmente importante in un contesto storico in cui tali discipline si confrontano con l’ineluttabilità di alcune configurazioni di disagio territoriale, sia nelle aree rurali che in quelle urbane, dove troppo spesso “l’idea di un futuro implica un altrove” (p.38).
Merita un’ultima riflessione il tema della morte, e della sopravvivenza: come sappiamo, Civita porta spesso con sé l’appellativo “la città che muore”, ma leggendo l’opera di Attili viene da chiedersi se non sia invece un borgo che, nonostante tutto, sopravvive.
Se l’assunto di Pierluigi Crosta ci ricorda che il territorio “è l’uso che se ne fa”, e che l’abitare in fondo è esito di una produzione di habitus, è anche vero che i luoghi esistono a prescindere da (talvolta, nonostante) la nostra presenza – e forse questo ci avvicina ad alcune posizioni di critica all’antropocentrismo che ci invitano a riconsiderare la relazione che da sempre l’umano ha intrecciato con i territori che lo ospitavano. Un paradosso che è stato ancora più evidente con l’arrivo del covid: il vuoto perturbante delle nostre città ci ricordava come il costruito si svuotasse di significato senza che qualcuno lo abitasse; al tempo stesso la natura avanzava, imperturbabile, in una strana campagna di riconquista dei centri abitati, come a ricordarci che in fondo, sul pianeta, gli ospiti dalla presenza più effimera possiamo tornare ad essere noi e i luoghi, alla fine, ci sopravviveranno.
Titolo: Civita. Senza aggettivi e senza altre specificazioni
Autore: Giovanni Attili
Editore: Quodlibet (collana Quodlibet Studio. Città e paesaggio)
Pagine: 400
Prezzo: 32 €
Anno di pubblicazione: 2020











